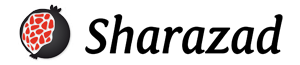Amo chi si è costruito una cultura del metodo. È qualcosa che aiuta ad affrontare i problemi e le sfide con coscienziosità e rigore. Il “metodo” ci ricorda Cartesio, Galileo e Feyerabend. I metodi che insegnano gli esperti di Lean, di Agile, di Design Thinking sono sorprendenti e appassionanti. Sono l’esito di decenni di esperimenti, errori demotivanti e scoperte entusiasmanti. Sono l’espressione migliore dell’attuale modo di organizzare il lavoro.
Qualcosa però non torna. Saper utilizzare una bussola ci consentirà di trovare la strada giusta? Chi ci insegna un modo per affrontare i problemi, ce li risolve davvero?
Aspettative scarse
Dipende ovviamente da cosa ci aspettiamo da chi ci insegna un metodo. Ci attendiamo che un insegnante di disegno ci faccia diventare Picasso? Ovviamente no. Ci sono dietro il talento, la maestria e la dedizione e tanti altri fattori individuali e di contesto che impattano pesantemente.
È in questo senso bello il racconto di F*ing Genius di Massimo Temporelli sui geni della storia della scienza. Spesso le puntate fanno riferimento al rapporto tra qualità individuali e contesto in cui possono esprimersi.
Venendo al punto, nelle diverse attività in cui l’avventura di Sharazad mi trascina, spesso mi ritrovo nel ruolo di consulente, di fidato consigliere. A volte portatore di metodo, a volte creatore di idee. E qui viene il punto più difficile. Che tocca alla radice la relazione tra strumenti e loro utilizzo. E tocca anche una certa interpretazione della Business Agility che recentemente ho riscontrato anche in un libro completo e ricco come quello di Fabio Lisca.

Invasioni di campo
Per buona parte della mia crescita professionale ho pensato che chi fornisce gli strumenti tecnici per gestire le idee, più o meno innovative, che caratterizzano la storia di un’impresa non debba invadere il contenuto. Io ti do modo di far nascere, di organizzare e di sviluppare diverse iniziative, ma mi fermo lì. Sarebbe un’invasione di campo darti idee mie. È compito tuo, imprenditore o manager, prenderti il rischio di decisioni sul da farsi.

Questo è il limite di tanti “consiglieri”, commercialisti o consulenti che siano. Ma anche di molti manager. Il metodo è essenziale, ma non basta. C’è qualcosa che riguarda la creatività. Che è una cosa che è indiscutibilmente legata al metodo. Scaturisce dal metodo, ma non è il metodo.
Skin in the game
Cerco di spiegarmi. Mi ha urtato, ma mi è servito, quel solito fastidioso libro che è Skin in the Game di Nassim Taleb. L’avevo preso alla leggera. I consulenti di ogni risma si limitano a dare consigli (“Fai quell’investimento”, “Inizia quella guerra”, “Assumi altre persone”). Ma non si mettono a rischio. Applicano metodi e si fanno pagare. Sembrava semplicemente una sfida a farsi retribuire in base ai risultati. Ma poi ho realizzato che non si trattava solo di quello.
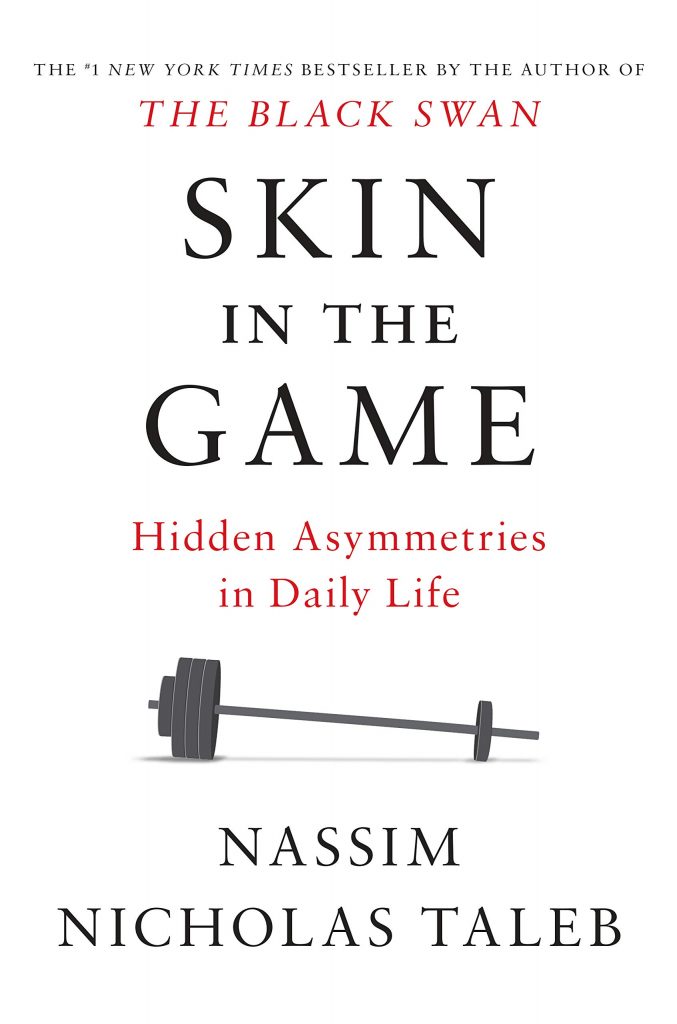
“Skin in the game” significa prendere posizione, non limitarsi a fornire piattaforme metodologiche, agili, snelle o creative che siano. Il metodo che non solo accompagna, ma guida. E allora oggi dal manager, dal consulente, dal designer, dal commercialista e dall’avvocato, da ogni tecnico si pretende di affiancare al rigore metodologico un atto creativo. Sporcarsi le mani e prendersi dei rischi. La decisione la lasciamo poi all’azienda, ma il nostro partner deve poter stabilire se le nostre idee sono risultate utili. La sfida è affiancare l’intuito sul business al metodo strutturato.
L’inganno del metodo nel marketing
Per chi fa marketing ad esempio significa non limitarsi a insegnare un processo ben eseguito. Si deve produrre uno scarto tra il cliente e la sua concorrenza. Per farlo bisogna fare qualcosa di diverso dagli altri e quindi in qualche modo non seguire il metodo più alla moda.

Non vendiamo panacee. Non possiamo dire che chiunque utilizzi Hubspot avrà successo. O che una buona impostazione di campagne web ci farà vendere. Non si può in generale dire che chiunque applichi il metodo proposto avrà successo. E che quindi il metodo applicato sia garanzia di un risultato. Se tutti applicano lo stesso metodo, poi in realtà non tutti vincono. C’è qualcos’altro che scaturisce dalla fantasia, dagli unfair advantage, dal caso e dalla fortuna.
L’ambiguità dell’Agile
Quindi per utilizzare al meglio il metodo dobbiamo essere convintamente contro l’apologia della buona applicazione del metodo. Ma non è quello che sempre vedo in una certa parte del mondo Agile. L’idea First who, then what che metteva al centro le persone rispetto alle procedure era parte dell’approccio Lean tradizionale. Come nella classica dialettica delle idee, portata all’estremo, la matrice Lean si è tradotta nel contrario. Cito testualmente.
Il talento, il genio, il self-made man sono miti auto-celebrativi del successo e su questo sono stati scritti migliaia di libri su come si fabbrica il successo partendo dal punto di vista sbagliato, ovvero come sono le persone di successo e come si comportano. […] Forse è arrivato il momento di cambiare paradigma e di iniziare a pensare in termini di auto-imprenditorialità, creando ambienti dove tutti possono portare il loro contributo, tutti possono dar vita alle loro idee, tutti possono creare innovazione e diventare intra-imprenditori. Il merito non ci serve, tutti sono meritevoli di portare il loro contributo.
Lisca, Fabio. Business agility. Franco Angeli Edizioni
Mi piace sulla carta. Fa leva sulle idee di Daniel Kahneman e altri grandi autori che non possiamo non apprezzare. Ma è ambiguo. È ambiguo come tutte le grandi utopie. Come quelle che dicono che per garantire l’equità devo perseguire l’uguaglianza. È una miopia che ha caratterizzato e ancora caratterizza molto pensiero economico e politico.
Alla fine ce la prendiamo con la meritocrazia e il pensiero è sicuramente seducente. Il contesto, la pari opportunità, le condizioni al contorno abilitano storie di successo. Sulla carta giusto, ma nella realtà frustrante, demotivante e omologante. Perché poi viene portato alle estreme conseguenze, lo sappiamo, in cui l’illiberale macchina burocratica opprime l’individuo.
Il metodo, il processo e le tecniche Agile sono trampolini per spiccare il volo. Non rendiamole gabbie per omologare verso il basso i talenti delle nostre aziende. Neanche se siamo mossi dalle buone intenzioni.